A proposito de “L’Illuminismo mio e tuo”
I due illuministi
Mondadori pubblica lo scambio di lettere e riflessioni critiche tra Italo Calvino e Leonardo Sciascia. Ne scaturisce un ritratto inedito dei due scrittori, uniti dalla necessità di analizzare la realtà con le armi della ragione
Nel canone italiano del secondo Novecento, due sono gli esempi più eclatanti di scrittori intorno ai quali è andata cristallizzandosi, per troppo tempo, un’immagine assai riduttiva, frutto di luoghi comuni e fuorvianti semplificazioni: Italo Calvino, alfiere di un principio di “leggerezza” assai frainteso, sul quale a lungo è pesata la condanna d’un eccesso di cerebralità; Leonardo Sciascia, ridotto a mero antropologo della mafia e della mentalità siciliana, santo protettore dell’impegno in letteratura. Ricezione mutila che non si è perso tempo a trasferire anche in ambito scolastico.
La riflessione è suggerita dalla recente uscita dell’epistolario dei due scrittori, L’Illuminismo mio e tuo. Carteggio 1953-1985 (Mondadori, Oscar Cult, 2023), a cura di Mario Barenghi e Paolo Squillacioti, 145 tra lettere e altri tipi di missive inviate, in modo complessivamente omogeneo dai due, nel corso di più di trent’anni, con un più fitto scambio di corrispondenza tra gli anni Cinquanta e Sessanta, destinato ad affievolirsi nei decenni successivi. I curatori hanno radunato il corpus delle lettere, conservate, quelle inviate dallo scrittore siciliano all’Archivio di Stato di Torino (Fondo casa editrice Einaudi); quelle del ligure reperite invece presso la Fondazione Sciascia a Racalmuto.
Sarà Mario La Cava a sollecitare l’amico Sciascia perché richieda a Calvino l’invio di una copia del gettone dei Caratteri (1953) da recensire su «Galleria», senza peraltro perdere occasione d’invitarlo a collaborare alla rivista. Da quel momento in poi Calvino diventerà per Sciascia il solo interlocutore di cui ha piena fiducia in casa Einaudi: suo primo lettore, consulente, ammiratore, severo critico. Uno Sciascia assai battagliero perché Einaudi si adoperi a dare il giusto rilievo alle sue opere, come accade per la travagliata prima edizione nei «Gettoni» di Vittorini degli Zii di Sicilia e la riedizione, con l’aggiunta di Antimonio, il racconto sulla guerra civile spagnola, nei «Coralli», nel 1959. Non stupisce affatto scoprire lo scrittore siciliano così attento alla cura delle sue opere, al loro destino, e sempre pronto a incalzare l’editore per ogni mancanza. Instancabile nel sollecitare responsi a Calvino per i suoi nuovi libri (sarà così anche per Il giorno della civetta); sensibile anche alla questione del tempo più idoneo all’uscita dei suoi libri…
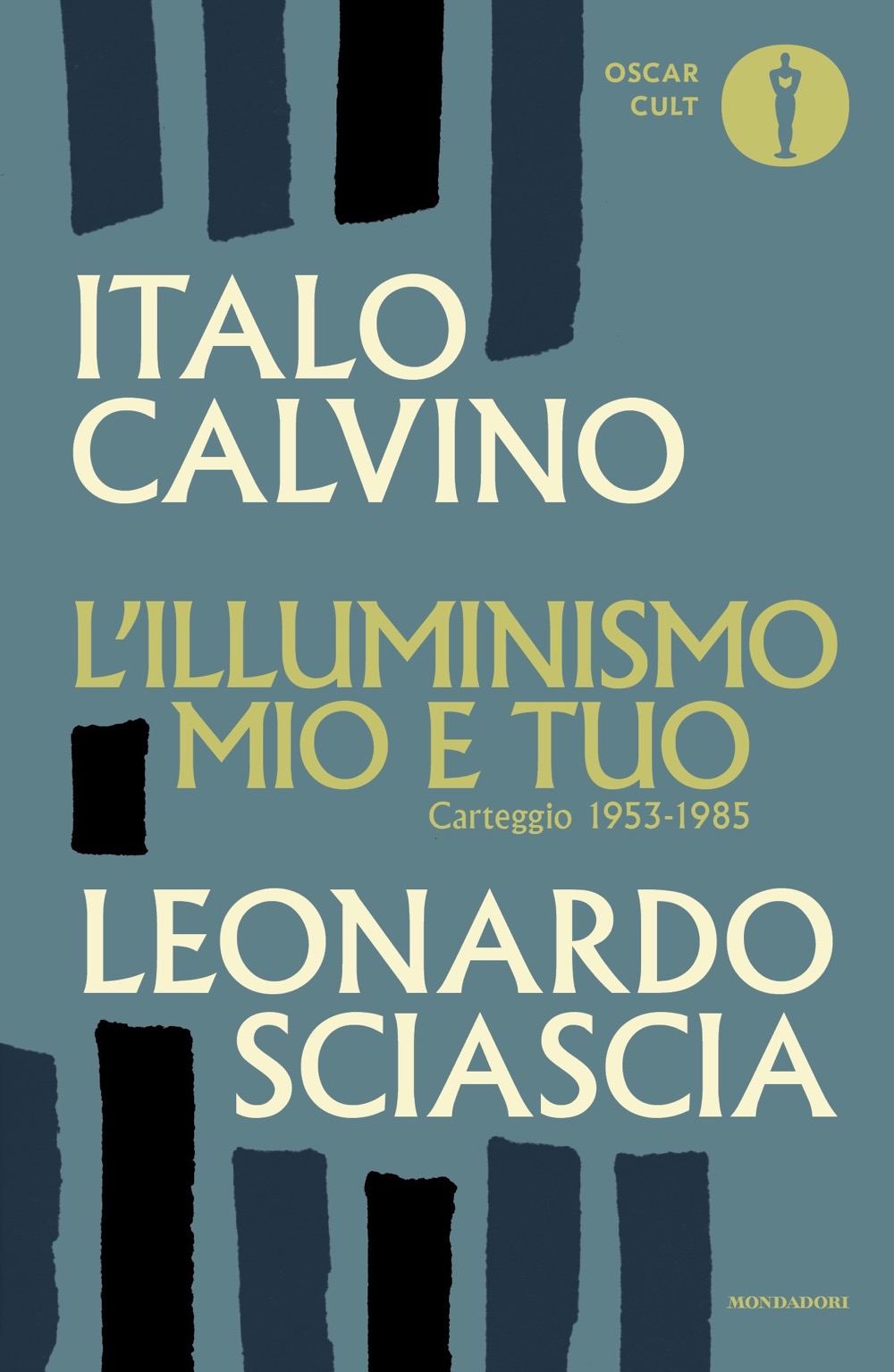
Ma ciò che in maniera evidente si ricava dall’epistolario è l’assurgere, l’uno per l’altro, con reciproco riconoscimento, a «ottimo dei lettori» (Calvino a Sciascia, 18 gennaio 1958): «il migliore che si possa desiderare» (Sciascia a Calvino, 26 ottobre 1960). Cruciale la lettera da cui i curatori hanno estrapolato il titolo per l’epistolario: «L’illuminismo mio e tuo». A sollevare la questione di quell’eccesso di controllo, di quella nevrosi di voler calibrare tutto che li accomuna, sarà Calvino quando, a proposito della commedia L’onorevole (1965), eromperà nella finta rabbiosa petizione di uno Sciascia che abbandoni il controllo della pagina, per far aggallare, senza freni, se stesso «col suo dèmone»: il suo momento personale e lirico, che mandi in frantumi la maschera e il mito finora autoedificato. Nel parlare di Sciascia, Calvino non può non pensare alla sua personale storia di autore che non riesce a cedere totalmente al proprio dèmone («parlo di te per cercar di veder chiaro anche in me» (L 115, pp. 162-163): confronta la loro superficie da razionali e illuministi; illuminismo in lui ibridato con il fantastico, l’umoristico, il non-sense e la fumisteria; in Sciascia, per quanto lo riconosca assai più integralmente illuminista, immerso nell’humus siculo-ispanico, che vuol dire Pirandello, ma anche Cervantes («una serie di cariche esplosive sotto i pilastri del povero illuminismo in confronto alle quali le mie sono poveri fuochi d’artificio»). E così conclude: «Sii ispano-siculo e magari arabo-siculo fino in fondo e vedrai che sarai universale».
È questo il tenore dello scambio tra due acuminatissime intelligenze critiche sempre al lavoro, protese alla ricerca di una problematicità da sviscerare: una vicinanza, pur nei differenti orientamenti ed esiti, che potremmo definire di metodo o più semplicemente di approccio: vivere la realtà come carta da decifrare; intendere la letteratura come grimaldello gnoseologico per carpirne tutta la complessità. Emblematico ancora, in tal senso, lo scambio epistolare del novembre del ’65 (cfr. LL. nn.117-118): lettore mai passivamente empatico, Calvino non si lascia scappare l’occasione di rifilare all’amico un «boccone amaro», trovando in A ciascuno il suo (1966) quella asfittica e totalizzante conoscenza del mondo siciliano e della sicilianità che si ricava dalla lettura dei romanzi di Sciascia, per cui la Sicilia diventa «la società meno misteriosa del mondo»; essendo la soddisfazione ricavata dalla lettura di queste storie siciliane comparabile a «una bella partita di scacchi», al piacere delle combinazioni fornito da «un numero finito di pezzi a ognuno dei quali si presenta un numero finito di possibilità». Sciascia replica descrivendo l’insensata condizione di scrivere della Sicilia dalla Sicilia: da una Sicilia che rassomiglia sempre più a un deserto o a un cimitero, in cui non resta che il piacere e l’amarezza «di combinare all’infinito un numero finito di pezzi» (colpisce senz’altro qui il rimando comune alla metafora combinatoria del gioco che caratterizzerà le opere di Calvino da questo momento in poi).
In coda all’epistolario troviamo una sezione degli “Scritti reciproci” di argomento letterario e politico: oltre ai risvolti di copertina, scritti da Calvino per Gli zii di Sicilia, Il giorno della civetta e la Recitazione della controversia liparitana, si riporta la riflessione del ligure al tempo della pubblicazione di sei lettere inedite sul numero monografico della rivista «L’Arc» (n.77, 1979) dedicato a celebrare Sciascia, in cui ammette che il confronto serrato con il farsi dell’opera dell’amico ha funzionato anche da diario, autoriflessione sul fatto letterario in sé e sulle possibilità del narrare. Di Sciascia, invece, viene riportata la recensione al Barone rampante, il libro della vittoria della fantasia-poesia (sempre storica e morale in Calvino), espressione di estrema libertà: scritto di getto e frutto di un furore ribelle, vista anche la contingenza storica di quegli anni e l’uscita dello scrittore dal P.C.I.; la superba ampia recensione all’edizione dei Nostri antenati, che aiuta retrospettivamente già a capire i nessi tra il fantastico del Calvino degli anni Cinquanta e il fantastico cosmicomico, insieme all’acuirsi, fino a diventare centrale, del problema del rapporto tra mondo scritto e mondo non scritto: con quell’attenzione di cui parla Calvino (e che Sciascia riprende nella recensione) all’atto stesso dello scrivere, al rapporto tra «complessità della vita e il foglio su cui questa complessità si dispone sotto forma di segni alfabetici» (p. 239).

Entrambi attraversano una fase di crisi intellettuale intorno alla prima metà degli anni Sessanta (si pensi a due libri spartiacque nella loro rispettiva produzione come La giornata d’uno scrutatore e A ciascuno il suo): un disagio, un critico attraversamento da cui scaturiranno le loro opere future. Gli anni Settanta, con le diversità di vedute che emergeranno circa alcune questioni del contesto storico-politico, porteranno a un progressivo diradarsi della loro corrispondenza. Alla polemica sul ritiro dei giurati popolari al processo contro i brigatisti del ’77 si aggiungerà la netta presa di distanza di Calvino rispetto alla tesi cui fece affidamento Sciascia per montare insieme L’affaire Moro (1979), per cui fu pura illusione credere che la comprensione della tragedia individuale dell’uomo Moro potesse comunque giustificare lo scendere a patti e il trattare da parte dello Stato. Eppure, più che il Candido (1977), è forse proprio questo il libro più calviniano di Leonardo Sciascia, in cui in maniera scoperta viene messo in risalto l’ufficio eminentemente conoscitivo della letteratura, potendosi di fatto leggere come un apologo sulla ricerca della verità sceverata dall’impostura.
Entrambi, entro un’aggiornata visione del canone letterario novecentesco, appartengono alla medesima linea genealogica, muovendosi sul doppio binario che coniuga razionalità illuministica e nevrosi per la continua ricerca di un metodo di descrizione-comprensione del mondo. Il vivere l’avventura della letteratura come detection, porterà Sciascia e Calvino a incrociare le loro piste letterarie, tra certificazione del caos per il siciliano e utopia di un ordine quantomeno ristabilito sulla pagina per il ligure, ragionando più o meno negli stessi anni, su di un medesimo rovello: «c’è sempre una carta che non trova posto» (si rammenti Una storia semplice, il romanzo terminale di Sciascia, e prima ancora La taverna dei destini incrociati di Calvino) – una falla, un inghippo, un conto che non torna nel tentativo di afferrare la verità.

