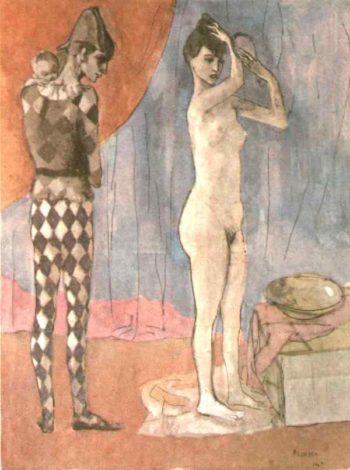Una novella inedita
La fachira a pranzo
«La fachira, la marchesa Igea Cuccurullo, aveva l’abitudine di venire a farci visita ogni giovedì, intorno all’una, mentre la mamma metteva i piatti in tavola»
Tra i tanti ricordi degli anni ‘50, un poco velati dal tempo, spicca invece nitido nelle teche della memoria il ricordo di una donna che chiamavamo la fachira. “Nonostante l’età – diceva – mi mantengo agile e snella, perché sono moderata: un tè senza zucchero al mattino e un solo pasto al giorno alla sette di sera”. In realtà era spaventosamente magra e, per questo, le mie sorelline ed io la chiamavamo la fachira.
La fachira, la marchesa Igea Cuccurullo, aveva l’abitudine di venire a farci visita ogni giovedì, intorno all’una, mentre la mamma metteva i piatti in tavola.
“Allora, marchesa – diceva la mamma – oggi è dei nostri? Pranza con noi?”
“No, per carità, la ringrazio, lei sa che ho altri orari.”
Avevamo calcolato, io e le sorelline, che le probabilità che accettasse l’invito qualora fosse stato rinnovato, potevano aggirarsi sul trenta per cento. Con un terzo tentativo, le probabilità salivano di colpo al cento per cento.
Era quella che si dice una buona forchetta e faceva piacere vederla all’opera: masticava, deglutiva e contemporaneamente parlava senza pause. Le ossa della struttura mandibolare, visibili in piena attività sotto la pelle raggrinzita, suggerivano un’immagine composita, qualcosa come una trebbiatrice, azionata da locomotore, sul quale fosse stato installato un magnetofono. Parlava di politica, economia, moda e varia attualità, ma più spesso della sua vita straordinariamente romanzesca, di cui tutti noi, eccetto il babbo, avidamente volevamo sapere. Procedeva per blocchi narrativi sintetici, assecondando uno stile di racconto asciutto, certo encomiabile, che, forse, sarebbe piaciuto a un caporedattore di un quotidiano, ma che a noi ragazzi lasciava inappagata una miriade di morbose curiosità. Per esempio, diceva: “Orfana, da bambina, portavo le pecore al pascolo. Un giorno, a quattordici anni, presso un ruscello, un cacciatore mi offrì un cioccolattino e mi sedusse”. L’incontro tra il rude cacciatore e la fanciulla, nella solitudine dei boschi, avrà avuto sommesse parole d’amore? Parole forse rozze, ma pregne di sottili inquietanti allusioni? Come si montò, a poco a poco, irresistibilmente, la libidine? E il grido soffocato nel momento terribile, sublime e assoluto dell’addio al virginio fiore? E l’acqua sorgiva fra le rocce o il ruscello che, limpido e puro come il cuore della pastorella, solcava argenteo il prato erboso? E le pecore che, ignare, pascolavano quiete come in un sogno? Eccetera, eccetera. Non ci crederete ma questi erano i pensieri, gli interrogativi di un quattordicenne pieno di peli, ma romantico e, quasi certamente, anche di due vispe e graziose gemelle tredicenni, altrettanto romantiche. Ascoltavamo, però, a bocca aperta, senza chiedere, per il nostro pudore di ragazzi e, ancor più, per il severo divieto paterno espresso, in queste circostanze, da esplicite occhiatacce.
Il cacciatore era il marchese Giovanni Maria Cuccurullo, il quale si portò a casa la ragazza, adibendola al duplice compito di servetta e giovanissima amante.
La moglie del marchese, donna triste e misteriosa, era affetta da un male inesorabile. Quando, ancor giovane, morì, il marito che, forse, a suo modo le aveva voluto bene, piangendo sulla tomba e sentendosi in peccato mortale, fece solennemente voto di castità e decise di dare un’educazione signorile alla pastorella. Così, anche per allontanare da sé ogni tentazione, la mandò a studiare in un collegio di monache in Svizzera, presso Zurigo, dove Igea trascorse più di quattro anni della sua giovinezza.
Ebbe difficoltà nell’ambientarsi alla vita di collegio? Si legò d’amicizia con qualche compagna di studi? Le suore la trattarono con affetto? Quando, all’inizio della primavera, l monti intorno a Zurigo erano ancora ricoperti di neve, sentiva nostalgia della dolce campagna meridionale, dove, da bambina, aveva pascolato le pecore? O sentiva nostalgia delle carezze del marchese? Tutto questo non era dato sapere. Evidentemente la sua rigorosa essenzialità non lo consentiva.
Lasciò il collegio quando era diventata una signorina diciannovenne di grande avvenenza ( difficile, in verità, immaginarselo; gli occhi sì, erano ancora luminosi). Un telegramma le ordinò di accorrere al capezzale del suo tutore in fin di vita. Il marchese voleva presentarsi nell’altro mondo con la coscienza pulita, per cui al prete, che era lì per officiare l’estrema unzione, fu chiesto di celebrare un matrimonio in extremis. Insomma, in un solo giorno, Igea acquistò un nobile casato, una ragguardevole fortuna e una precoce vedovanza.
Giovane e ricca, ma ancora ingenua, ingenuamente si innamorò di un sottotenente di complemento, vivace, elegante e di bell’aspetto ma, in realtà, un cinico avventuriero, donnaiolo e incallito giocatore d’azzardo, che, come marito, fece pessima prova. Nel giro di due anni, infatti, sperperò l’intera fortuna della moglie. Incalzato da creditori d’ogni risma, da strozzini e ricattatori se ne scappò con una cocotte in estremo oriente dove, in una bisca a Hong Kong, durante una rissa, fu accoltellato. Per pagare i debiti contratti dal secondo marito e sfuggire a numerose minacce di morte, Igea dovette vendere il palazzo e la tenuta Cuccurullo, alla quale teneva più d’ogni altra cosa. Pertanto restò di nuovo vedova e, questa volta, povera in canna. Tuttavia non si perse d’animo: approfittando della sua perfetta conoscenza della lingua tedesca, chiese ed ottenne un posto di istitutrice presso la famiglia Blomberg, un alto ufficiale delle SS, in stanza a Roma. Vivendo con la famiglia Blomberg, Igea incappò nell’insana passione di Gertrude, la bellissima moglie dell’alto ufficiale.
Le mie sorelline ed io avremmo dato chissà cosa per conoscere i particolari dell’insana passione, ma ci dovemmo accontentare di un solo accenno: “ Gertrude era una donna di grande fascino, benché terribile e spietata. Faceva paura a tutti, anche al marito. Solo tra le mie braccia diventava un agnellino e io le facevo leccare i piedi” Tutto qua, ma sufficiente per innescare nella mia immaginazione e, credo, anche in quella delle gemelline, una serie di oscene fantasticherie.
Forte dell’ascendente che esercitava su Gertrude, Igea ottenne un salvacondotto per un’intera famiglia di ebrei, vecchi amici del marchese, destinati, altrimenti, al campo di sterminio di Dachau.
«Brava Marchesa! – disse mia madre – Questo le fa veramente onore; un gesto umanitario, che può riscattare molti peccati». E pronunciando queste parole, mi sembrò che la mamma volesse anche perdonarla di aver introdotto, nell’esposizione, l’episodio scabroso dell’amicizia particolare, tema quanto meno inadeguato per orecchie innocenti, che, poi, erano le mie e quelle delle mie sorelline.
Gli ebrei, in seguito, ricambiarono la cortesia, testimoniando una presunta fede antifascista ai partigiani che volevano fucilare la marchesa con l’accusa di collaborazionismo.
Con gli americani Igea ballò il buggy buggy, fece il contrabbando e si adoperò in altre indicibili attività, delle quali, infatti, preferiva tacere.
Finalmente un giorno, in una latteria a Piazza del Gesù, incontrò il grande amore: un lanciatore di coltelli. Il lanciatore se ne stava lì, col suo cappuccino, triste e sconsolato, perché la sua donna, invaghitasi del domatore di leoni lo aveva abbandonato.
Igea lo amò subito e per sempre. «Era l’uomo più buono e dolce del mondo» disse. Divenne la sua compagna nella vita e nel lavoro. Con lui, esibendosi nei circhi e negli spettacoli di varietà, girò tutto il mondo, visitò tutta l’ Europa, l’America, l’Australia, l’India, il Giappone e perfino la Cina. Conobbe principi e regnanti, uomini ricchissimi si innamorarono follemente di lei, ma Igea restò sempre fedele al lanciatore di coltelli, l’unico uomo , disse commovendosi, dal quale avrebbe voluto avere un figlio.
Quello che le accadde durante la terza vedovanza, la fachira non lo diceva. “Niente di interessante” tagliava corto. Ma si mormorava in giro che avesse avuto una larga partecipazione finanziaria in una catena di bordelli nel sud della Spagna e che avesse tratto da tali investimenti ingenti proventi. Certo è che era benestante. Possedeva case e terreni e anche il palazzo, del quale abitavamo in quell’epoca, un appartamento al terzo piano, era di sua proprietà.
Versatile nelle arti dello spettacolo, la marchesa, specialmente se aveva bevuto qualche bicchiere in più di frizzantino, di cui andava matta, era disposta a recitare e a cantare. Tra le poesie privilegiava la Spigolatrice di Sapri, che diceva con grande passione. Anzi con la spigolatrice il diapason emozionale saliva al vertice immediatamente sin dalle prime battute: “ Eran trecento. Eran giovani e forti” e ancor prima che a voce spiegata dicesse “E sono morti” già due lacrime le scendevano lungo gli anfratti del viso. Anche alla mamma venivano i lucciconi. Le gemelline facevano strane smorfie per contenere il riso, mentre mio padre leggeva il giornale e sbuffava. Lui non era d’accordo con gli inviti a pranzo alla marchesa e considerava le storie autobiografiche e le strepitose esibizioni artistiche della vecchia pazza, come la chiamava, disgustose e antieducative. Il babbo, però, era stato messo in minoranza, anche perché la mamma aveva introdotto un argomento di indubbia efficacia persuasiva: la carità cristiana. “ E’ una povera donna sola, senza amici. Il Signore ce ne renderà merito.” Così, per non perdere completamente la partita, il babbo ripiegò su un’inderogabile alternativa: o il cinema alla domenica o la marchesa il giovedì.
Dopo il dramma di Pisacane e compagni, puntualmente veniva la comica finale. In quest’ambito, il cavallo di battaglia della Fachira era La Ninì tirabusciò, con relativa mossa, a viva richiesta del coro. Ogni strofa della Ninì produceva irrefrenabili risate. Solo il babbo continuava a leggere il suo giornale, dando appena qualche sbirciata al di sopra degli occhiali, ma io sospettavo che facesse uno sforzo per non ridere a crepapelle anche lui. La mamma, invece, si scompisciava, nonostante una volta avesse temuto per il suo tappeto persiano, che era costato un occhio ed era il pezzo forte del nostro salotto. Accadde, infatti, che le risate incontrollate della marchesa, allentando gli inibitori fisiologici, determinarono un’abbondante minzione, la quale scorrendo dolcemente lungo le gambe rinsecchite, irrorò il pavimento in uno spazio scenico, vicino al pianoforte e non molto distante dal prezioso tappeto. La cosa più strana fu che la fachira mostrò di non accorgersi assolutamente di nulla.
Quando se ne andò, alle gemelline venne assegnato il compito spiacevole di pulire, disinfettare e arieggiare la stanza. Io, in qualità di maschietto, fui esonerato dalle umilianti incombenze, ma non da una sorta di collettiva responsabilità morale, che il babbo, rosso come un peperone per la collera, ampiamente rimarcò, ripetendo la frase tre volte, come suo costume in questi casi”Ho vergogna della mia famiglia! Hovergogna della mia famiglia! Ho vergogna della mia famiglia!”
Per fortuna la mamma rimise tutto nelle debite proporzioni: “Che vuoi che sia un po’ di pipì! Quando qualche rara volta mi diverto un poco, sembra che ti dispiaccia. Eppure, con la vita che conduco, credo di averne il diritto.
Poi con una sortita filosofica più universale, concluse: “Oggi come oggi, coi tempi che corrono, sotto la minaccia di una guerra atomica, che può distruggere l’intero genere umano, una risata, di tanto in tanto, fa bene! È tutta salute! È tutta salute!”